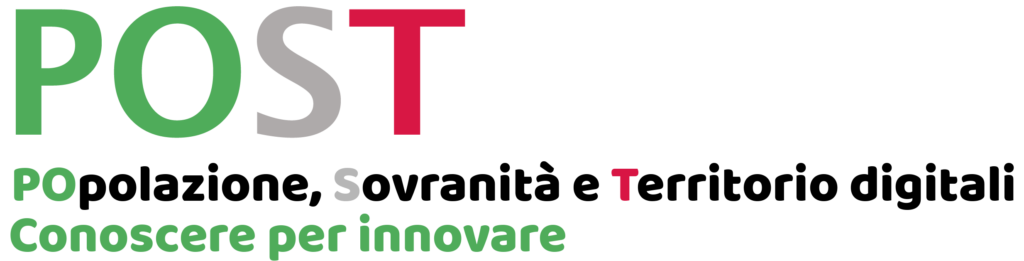Di Gianpiero Ruggiero - Esperto CNR in processi di innovazione
–
Che la tecnologia abbia impatti sulla realtà sociale e lavorativa è ormai di dominio pubblico.
La nuova rivoluzione industriale, quella dei robot, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, non può essere fermata.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rendono molte cose più semplici rispetto al passato; servizi che prima richiedevano lo spostamento fisico e lunghi tempi di attesa sono oggi a portata di touch, veloci e immediati. Internet, big data, tecnologie blockchain e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando ogni ambito della nostra vita. La nostra generazione – scrive il filosofo Luciano Floridi – sarà probabilmente l’ultima ad avere ancora chiaro che cosa significa vivere offline e online, il futuro sarà “onlife”.
Siamo di fronte a un balzo in avanti dell’umanità. Ma per farne un’opportunità di progresso e di benessere collettivo dobbiamo guidarla.
I pericoli, però, non sono da negare. La fase che attualmente stiamo vivendo è paradossale, con creazione di grandi opportunità, ma con la preoccupante riduzione dell’occupazione e la formazione di piramidi e strettoie: se la tecnologia non va demonizzata, vanno tenuti in considerazione i rischi che essa comporta.
Sappiamo che il benessere sprigionato dopo il secondo conflitto mondiale si è fermato da tempo, anche in termini di tutela sociale (storici ed economisti sono concordi sul punto). Un dato si conferma allarmante: la concentrazione dei benefici. Gli incrementi reddituali a partire dagli anni ‘80 si sono concentrati nelle mani di una minoranza. Questo ha generato disuguaglianze e la qualità di vita della classe media è peggiorata.
Nel tentativo di diventare una nazione tecnologicamente più progredita, stiamo rischiando di lasciare indietro una buona fetta di popolazione che fa fatica a districarsi nell’infosfera o che addirittura non ha alcuna dimestichezza con le tecnologie, soprattutto quelle digitali.
C’è un divario formativo e di conoscenza che è altrettanto profondo ed esteso rispetto a quello infrastrutturale. E il fenomeno è più ampio di quello che si pensi. Peraltro la tecnologia spinge verso una specializzazione delle conoscenze e delle capacità; la possibilità di perfezionarle è dirimente nel lavoro dei prossimi tempi. Questo aspetto sfugge alla scelta dei singoli: spesso non si ha possibilità di una formazione adeguata.
È necessario perciò che le persone si preparino per il nuovo mondo digitale e che le aziende, incoraggiate e sostenute dalla politica, giochino un ruolo importante nel preparare le persone e accompagnarle in modo creativo nella nuova economia digitale.
Sarà importante, nel pianificare il futuro del Paese, non dimenticarsi di chi vive in quella zona grigia in cui il digitale fatica a vedere la luce. La sfida è sostanzialmente aperta e coinvolge in primo luogo l’autorità pubblica e l’azione politica. Occorre dare a tutti le stesse possibilità.
Le ineguaglianze, in ogni caso, appartengono già alla realtà attuale, anche senza machine learning e software “predittivi”. È una realtà antica, come la storia che l’accompagna. Va contestualizzata alla tecnologia, altro sapere antico con cui l’uomo plasma e modella la natura ai propri fini. Per questo l’era digitale riguarda anche il sistema di regole e di tutele giuridiche che sapremo darci per indirizzare l’evoluzione tecnologica verso obiettivi più equi, di sviluppo sostenibile e di benessere generale.
Per avere un’era digitale etica, servono uomini etici.
Progettare insieme tecnologia, organizzazione e lavoro
Vorrei parlare di lavoro e innovazione facendo riferimento ai tre elementi fondativi di qualsiasi organizzazione, da implementare in modo organico.
La tecnologia, l’organizzazione e il lavoro.
Il mondo in cui viviamo è estremamente complesso, ma se basiamo il processo di cambiamento su questi tre elementi avremo un percorso di innovazione e progresso ben definito, altrimenti sarà una corsa a ostacoli che rischia di impoverire qualsiasi tentativo.
Il sociologo dell’organizzazione Federico Butera spiega che in ogni organizzazione sono presenti, oltre all’organizzazione formale, anche diversi strati coesistenti di sistemi di regolazione sociale o tecnica: la cultura, i ruoli lavorativi agiti, il sistema professionale, le comunità di pratica, le tecnologie, “il posto di lavoro che c’è dentro le persone” e molti altri.
Si tratta dell’organizzazione reale, quello che c’è sotto la punta dell’iceberg di organigrammi, procedure, mansionari.
Se i tre elementi non sono convergenti, l’organizzazione diventa una arena di conflitti che il management cerca di regolare con una crescente burocrazia o creando procedure scollegate affidate alle responsabilità di silos funzionali (IT, HR, Finanza, Formazione, Comunicazione, Marketing, ecc.).
Che fare quindi per sviluppare le organizzazioni del futuro?
Come valorizzare il lavoro?
La proposta che molti economisti avanzano, alla quale aderisco, è quella di progettare insieme tecnologia, organizzazione, lavoro nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nel terzo settore, perché ogni organizzazione sia un sistema efficiente, sostenibile, giusto e perché crei valore aggiunto e lavoro di qualità.
Progettare insieme vuol dire anche partecipazione di istituzioni, imprese, ricerca, scuola, sindacati, mondo della cultura e soprattutto dei lavoratori e degli utenti.
L’organizzazione reale si analizza e si progetta in modo integrato con la partecipazione delle persone e il supporto delle tecnologie.
Gli studiosi delle scienze organizzative hanno dimostrato che da tempo si è creata una distanza tra le migliori imprese, quelle capaci di mettere le persone al centro dell’innovazione, che sanno che oltre all’aspetto monetario dello stipendio ci sono altri fattori altrettanto determinanti, da cui trarre vantaggio in termini di produttività e di soddisfazione dei singoli lavoratori, e il resto delle aziende, meno brave a gestire le innovazioni o in cui la tecnologia viene usata contro le persone (vedi i rider o le aziende che non riconoscono i diritti dei lavoratori).
Le migliori imprese valorizzano l’intelligenza umana e mettono al suo servizio quella artificiale. Sanno che il lavoro è una tastiera molto ampia, fatta di toni alti e bassi, ma tutti indispensabili. Le imprese di cui parlo fanno crescere tutte le professionalità, dalle più comuni alle più rare. E sono brave soprattutto a organizzare.
Organizzarsi per progettare cosa, con quale fine?
L’impresa crea valore e lavoro ma può anche danneggiare l’ambiente fisico e sociale, la qualità della vita delle persone, e spesso lo fa. Per questo si suggerisce il concetto strutturale di “impresa integrale”, che persegue e raggiunge insieme risultati economici e sociali, cosa che la rende “capace di durare”.
In questo processo di progettazione, oltre alle alternative di prodotto o di servizio, spesso sono contenute le grandi opzioni sul modello di economia e società.
In un periodo storico come questo, in cui l’egemonia della finanza sull’economia si va attenuando, le opzioni culturali ed etiche pesano: dal modello di crescita indefinita, a quello dell’economia circolare, dal soddisfare bisogni superflui dettati dal consumismo, piuttosto che offrire prodotti e servizi per soddisfare bisogni assoluti o evolutivi delle persone.
I potenziali benefici del passaggio a un’economia circolare si estendono al concetto di sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. Questa pratica offre alle organizzazioni grandi e piccole un percorso per ridurre i costi di produzione, utilizzando meno materie prime e soddisfacendo al contempo le richieste dei clienti in nuovi modi.
Il concetto di economia circolare rappresenta l’evoluzione sostenibile dell’attuale economia lineare.
Progettare tecnologia, organizzazione, lavoro in una visione e finalità “trumpiana” non è lo stesso che farlo in una visione “francescana” (in riferimento all’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco).
Organizzazione e tecnologie digitali: un amore tumultuoso, alla Via col vento!
Parlare di innovazione e di progresso comporta guardare all’interazione che si crea fra le tecnologie adottate e le persone che lavorano in un’organizzazione. Se è vero che mediante le tecnologie digitali si possono condizionare e modificare i comportamenti umani, è anche vero che sono le persone a decidere come utilizzare le tecnologie, rafforzandone, modificandone o annullandone le potenziali funzionalità.
Sviluppando le intuizioni e i principi dell’interazione uomo-macchina (human-computer interaction theory), la “relazione” fra le tecnologie digitali e l’organizzazione non è più interpretabile come un “matrimonio stabile”, piuttosto va narrato come un “amore tumultuoso”, alla Via col vento, per almeno quattro motivi.
In primo luogo, le tecnologie digitali sono considerate il risultato dell’azione delle persone, in quanto ovviamente sono degli artefatti, cioè prodotti materiali di programmatori, ingegneri, tecnici, manager, sviluppatori, e come tali riflettono le ipotesi e gli obiettivi dei loro progettisti e creatori. Allo stesso modo, le tecnologie digitali sono degli artefatti utilizzati dalle persone, le quali se ne appropriano e le adattano alle proprie esigenze, necessità, compiti, obiettivi. È il cosiddetto addomesticamento delle tecnologie digitali.
In secondo luogo, le tecnologie digitali sono considerate come “mediatori” e facilitano o vincolano i processi decisionali delle persone. Infatti, i dati di per sé non esistono in natura, esistono quando iniziamo a dare loro un senso e un’interpretazione. Solo allora iniziano a influenzare il contesto in cui le persone agiscono, il modo in cui decidono e in modo in cui apprendono.
È importante chiarire che le tecnologie digitali di per sé, in quanto artefatti, non sono strutture sociali, né tanto meno incorporano strutture sociali: solo quando i dati, i principi e le regole di elaborazione (si pensi ai social media) sono utilizzati dalle persone allora essi sono attivati e condizionano il comportamento delle persone stesse. Pertanto, l’influenza delle tecnologie digitali non è diretta. Se le persone si appropriano delle tecnologie e decidono di utilizzarle secondo modalità, criteri e per obiettivi diversi da quelli che sono stati immaginati dai progettisti o dagli ingegneri, possono incorrere in pericoli. Le persone possono sbagliare a usare le tecnologie digitali, possono sabotarle, possono imparare a utilizzarle lentamente e con ritardi e resistenze, oppure possono ignorarle e non utilizzarle. Quindi, si può concludere che è il modo in cui sono utilizzate le tecnologie digitali, e non le tecnologie di per sé, che definisce una forma organizzativa.
In terzo luogo, occorre specificare che l’interazione fra tecnologie digitali e comportamento non si sviluppa nel vuoto, ma all’interno di un preesistente e specifico contesto sociale composto da modelli di azioni dichiarati e in uso, da strutture di potere, di norme e di significati condivisi. Ovviamente, a queste strutture si rifanno le persone anche quando si rappresentano, decidono e apprendono. È molto difficile scardinare questi modelli mentali.
In quarto luogo, quando le persone utilizzano le tecnologie digitali mettono in atto comportamenti che possono rinforzare le strutture sociali del contesto, oppure metterle in discussione e modificarle. Il successo dell’inserimento di nuove tecnologie digitali è mediato dal contesto sociale in cui tali tecnologie sono adottate. Le organizzazioni possono scegliere come utilizzare la digitalizzazione, per modificare ad esempio le routine e le pratiche con cui svolgono i processi che compongono la teoria dell’azione in uso (sense making, decision making e knowing).
Tenendo conto di tutti queste relazioni, in ogni singola organizzazione l’interazione fra persone e tecnologie digitali si può sviluppare in modo diverso, ed è utopico immaginare che sia una interazione serena e senza tensioni o conflitti. Come affrontare dunque la relazione fra organizzazione e tecnologia ai tempi del digitale?
Forse un suggerimento lo dà proprio Gabriel García Márquez (L’amore ai tempi del colera): «Rispondigli di sì, anche se stai morendo di paura, anche se poi te ne pentirai, perché comunque te ne pentirai per tutta la vita se gli rispondi di no».
I robot ci ruberanno il lavoro?
Quante volte abbiamo pensato che le tecnologie di automazione, i robot, l’intelligenza artificiale ci ruberanno il lavoro.
Ma è proprio così?
Ci sono due correnti di pensiero contrastanti: gli ottimisti e i pessimisti. Ogni corrente di pensiero viene supportata da studi e ricerche. Io per natura sono ottimista, ma non devo convincere nessuno, anche perché misurare la portata dell’economia digitale non è semplice.
Mi limito a osservare tre fenomeni;
- Nei Paesi dove l’intensità robotica è maggiore (cioè il numero di robot di ultima generazione per numero di abitanti), come Giappone, Corea del Sud, Singapore e Germania, si registrano tassi di disoccupazione molto bassi.
- Il report della Banca Centrale Europea “L’economia digitale e l’area dell’euro[1]”, che ha misurato la correlazione tra occupazione e attività digitali, ha messo in luce che, nelle economie avanzate, nel decennio 2006-2016, i settori con maggiore intensità digitale hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita dell’occupazione. La BCE arriva alla conclusione che “le economie con una quota più elevata dell’economia digitale sul valore aggiunto totale tendono a essere quelle con tassi di disoccupazione più bassi”.
- I dati analizzati nei Paesi più fortemente dipendenti dal digitale, ad esempio Finlandia, Svezia ed Estonia, costantemente in cima alle classifiche dell’occupazione digitale, suggeriscono un forte contributo dei settori ad alta intensità digitale alla crescita dell’occupazione totale.
L’analisi di questi fenomeni sembra contrastare l’idea che un più elevato livello di digitalizzazione porti a una maggiore disoccupazione aggregata. Ciò non vuol dire che la digitalizzazione non si traduca in spostamenti e interruzioni del lavoro, per cui alcuni lavoratori perdono il lavoro e hanno difficoltà a riprendere un lavoro per periodi prolungati, ma la digitalizzazione genera anche nuovi opportunità e posti di lavoro. È molto probabile però che le nuove tecnologie, unitamente all’invecchiamento della popolazione, ci porterà tra qualche decennio ad avere nuove opportunità di lavoro che oggi ancora non conosciamo. Si pensi che il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari faranno dei lavori che al momento non esistono. Lavori che oggi non sappiamo prevedere.
Il dubbio se la digitalizzazione comporti più occupazione o più disoccupazione comunque resta.
La verità è che non sappiamo dare una risposta certa e univoca.
Ma dobbiamo aver presente che, come in passato, nell’era digitale non sono le macchine a licenziare e non sono le macchine a definire le forme organizzative. Non vi è spazio per scenari apocalittici: è vero che tecnologie avanzate distruggono alcuni lavori, ma il digitale è in grado di generarne anche di nuovi.
In questo senso la tecnologia può diventare fattore abilitante di nuovi lavori.
Questo non significa che dobbiamo diventare tutti scienziati dei dati o sviluppatori di algoritmi, ma prepararci a vivere una molteplicità di prospettive culturale.
La catena del valore dell’intelligenza artificiale, per esempio di tipo induttivo, quella che si basa sull’apprendimento delle macchine (il “machine learning”), ha alla base i dati, che vengono raccolti dalla realtà e da cui le macchine apprendono come classificare, come agire, cosa raccomandare, come prevedere le azioni future. Preparare le persone per questa nuova era del lavoro significa, perciò, sensibilizzarle sulla qualità del dato, sensibilizzarle a trovare il migliore collegamento tra la decisione da prendere, come persone, come manager, come lavoratore, e le fonti dove i dati si trovano. Questa abilità, il più delle volte trascurata nel proprio lavoro, diventa una competenza essenziale. Ridisegnare la realtà e i nuovi lavori richiedono capacità umanistiche, non esclusivamente nel campo delle scienze informatiche.
C’è spazio per ogni tipo di conoscenza per saper leggere e interpretare i dati. Tutti sono una risorsa. Nessuno è uno scarto.
Come diceva Alan Turing “c’è sempre l’uomo dietro i successi del computer”.
Questo ci fa capire l’urgenza di dover intervenire sul sistema degli ammortizzatori sociali (se reiterato all’infinito scoraggia le persone e fa perdere autostima), sul sistema educativo e scolastico, che ancora non riesce a colmare il gap di conoscenza e di alfabetizzazione digitale per quella schiera di ragazzi che tra qualche anno dovrà entrare nel mondo del lavoro. Ma ci interroga anche come integrare l’automazione intelligente nel substrato profondo delle organizzazioni e quali percorsi di riqualificazione formativa andrebbero sviluppati per tutti gli occupati di oggi.
Se è vero che siamo indietro nelle classifiche europee sui livelli di digitalizzazione (DESI), quanti lavoratori oggi sono male assortiti e avrebbero bisogno di ampliare le proprie conoscenze e competenze digitali?
Ma prima di parlare di aspetti formativi, occorre inquadrare meglio il discorso sugli impatti delle nuove tecnologie.
I dati ci dicono che l’Italia è tornata leader mondiale della produzione ed esportazione di macchine utensili, sorpassando la Cina che ci aveva recentemente superato. Ebbene, tutte le macchine utensili esposte nell’ultima fiera BI-MU utilizzano l’intelligenza artificiale.
Abbiamo detto che i robot, come l’intelligenza artificiale, sono manufatti.
Come ogni manufatto del passato, anche le nuove tecnologie di oggi portano dei cambiamenti e dei vantaggi. Se pensiamo all’elettricità, quando è stata inserite nelle fabbriche è stata utilizzata per fare le stesse cose in maniera più efficiente. Ci si è accorti che il motore a vapore poteva essere sostituito da un motore elettrico e che questo motore elettrico poteva essere distribuito ovunque all’interno di un’azienda, trasformando la catena produttiva e rendendola più efficiente.
Oggi una nuova ondata tecnologica sta cambiando il nostro modo di vivere. C’è un diluvio e questo diluvio è dato dall’intelligenza artificiale.
Lavorare con l’IA è qualcosa di simile all’avvento dell’elettricità nella seconda rivoluzione industriale (fordismo e taylorismo) perché, al pari dell’elettricità, l’intelligenza artificiale è considerata la nuova general purpose technology in grado di passare da un compito all’altro senza difficoltà e di influenzare un’intera economia.
L’importanza di una tecnologia del genere si può intuire pensando a come sarebbe scomodo il mondo se dovessimo utilizzare un computer per scrivere, un altro per inviare email, un terzo per navigare sul web, un quarto per vedere i film e così via, invece di avere a disposizione un dispositivo con una tecnologia in grado di passare da una mansione all’altra senza alcuna difficoltà.
Tante aziende che oggi si approcciano al digitale, iniziano a utilizzare l’intelligenza artificiale per fare le stesse cose di prima in modo più efficiente, quindi automatizzano il call center, le operation, il data entry, il back office. All’inizio scompaiono alcuni lavori di routine, più ripetitivi e prevedibili, e questa tendenza aumenterà in futuro. Ma poi i sistemi di IA, attraverso il metodo del transfer learning, iniziano a conservare parte dell’addestramento utilizzato per un compito e lo utilizzano per l’apprendimento di uno nuovo (un po’ come noi utilizziamo parte dell’addestramento per imparare ad andare in bicicletta anche per imparare ad andare in motorino), iniziano a scovare correlazioni, a comprendere il rapporto di causa effetto. A questo punto, in parallelo, nascono altrettanti nuovi lavori, che mettono in gioco la complessità del nostro cervello, più umani, più belli, che utilizzano di più la creatività.
L’automazione, perciò, all’inizio può portare alla scomparsa di lavoro, ma al tempo stesso alla creazione di nuovi servizi e nuovi modelli di business. Le abilità che saranno con molta probabilità più richieste in futuro saranno quelle che implicano spiccate competenze e abilità interpersonali, cognitive e di sistema[2].
Un modo sicuro per soffocare l’innovazione è non avere la maturità emotiva necessaria per riconoscere che l’innovazione e la creatività possono provenire da molte fonti.
C’è anche un altro fenomeno che emerge quando osserviamo i salti tecnologici.
Tempi sempre più stretti per metabolizzare i cambiamenti
Negli ultimi due secoli pensiamo agli impatti che hanno prodotto nuove scoperte che hanno cambiato il costume sociale e il sistema produttivo: invenzioni come il telefono, la radio, la televisione, il computer, soprattutto quello portatile, il cellulare, e più recentemente il web.
Oggi nessuno si chiederebbe se il telefono ci ruba il lavoro. Però dal 1870, da quando è stato inventato il telefono a oggi, possiamo notare che ciascuna di queste tecnologie ha impiegato tempi molto lunghi per diventare abbastanza diffusa (raggiungere ¼ della popolazione americana): il telefono ci ha messo 40 anni per entrare in ¼ delle case americane, la radio 30, la tv 25, il pc 15, il cellulare poco più di 10 anni. Il web ci ha messo ancora molto meno tempo.
Perché questo è importante?
Perché il telefono ha cambiato enormemente il modello di lavoro di molte persone: si è passato dal trasporto dell’informazione via posta al “ti telefono e te lo dico”. All’inizio del novecento questo ha cambiato radicalmente il panorama professionale e lavorativo di molte persone, scombinando tutto. Così come il computer, digitalizzando molte operazioni, sta scombinando oggi tantissime cose.
In passato i salti tecnologici sono avvenuti in tempi sufficientemente lunghi per la società, affinché la società potesse metabolizzare il cambio. Se la vita lavorativa di un essere umano è di 30/35 anni, davanti a una nuova tecnologia “disruptive”, che cambia il mondo del lavoro, che ci mette 20 o 30 anni a diventare pervasiva, il rischio per questo lavoratore è che si debba riqualificare una sola volta nella sua vita lavorativa. Diciamo che si può fare. Quando però le tecnologie che cambiano il mondo del lavoro, si susseguono con un passo quinquennale o con passo decennale, un lavoratore che vive nel mercato del lavoro per 35/40 anni si deve riaddestrare e riqualificare 3, 4 o 5 volte nella sua vita lavorativa. L’operaio specializzato deve acquisire subito le competenze di soglia richieste dalla fabbrica 4.0, per non rischiare di essere impiegato in attività più tradizionali destinate alla progressiva contrazione. Il chirurgo esperto, che non riesce a staccarsi dal bisturi e non sviluppa le abilità per manovrare il joystick come un bisturi, rischia di essere marginalizzato se la sua unità diventa una “sala operatoria 4.0”.
Siccome non parliamo di supereroi, questa diventa una sfida difficilissima per qualsiasi società avanzata, perché l’innovazione va metabolizzata. E il tempo della metabolizzazione riguarda la formazione, le scuole, l’assetto sociale, le regole, lo stesso individuo che si trova a passare dalla penna al mouse, dal mouse al comando vocale o all’assistente virtuale, al chatbot e così via.
È un problema che vediamo adesso per un semplice fatto di velocità. È la prima volta nella vita di homo sapiens che nell’arco della vita lavorativa le cose cambiano troppo e troppo in fretta. Prima più o meno riuscivamo ad adattarci. Oggi i robot e l’intelligenza artificiale ci hanno messo pochissimo tempo a essere pervasivi, ma non sono loro a rubare il lavoro, così come il telefono non ha rubato il lavoro in passato.
Il problema allora diventa di natura cognitiva, poi sociale e organizzativa, perché abbiamo davanti la grande sfida della conoscenza, del come si trasmette la conoscenza, delle competenze da acquisire. Il problema non si risolve parlando dei robot, il problema si risolve parlando di sapiens. Cioè del modello di società che vogliamo.
Tutte le tecnologie che sono state introdotte nel passato avevano esclusivamente come modello l’homo habiens. Cioè robot o macchina o tecnologia per l’aumento costante della produttività, crescita del PIL. Per molti anni tutti gli economisti hanno inseguito questo numero “magico”, come fosse il santo Graal. Questo ha generato un modello di sfruttamento delle risorse indiscriminato, prevaricatore, predatorio, basato sull’assunto che le risorse ambientali e naturali siano infinite.
Il modello di sviluppo che postula la crescita costante e infinita ha il suo rovescio della medaglia.
Ogni medaglia ha il suo rovescio
Ancora oggi ben oltre il 90% dell’energia, indispensabile per le evoluzioni tecnologiche, è prodotta da fonti tradizionali come carbone, petrolio, gas. Soltanto una piccolissima frazione dell’energia consumata è prodotta da fonti rinnovabili o non impattanti sull’effetto serra.
Oltre al consumo di risorse ecoimpattanti, c’è anche un altro problema, che attiene allo sfruttamento dell’uomo stesso.
Si pensi al lavoro degli uomini e spesso anche dei bambini nelle miniere di cobalto e litio (gli elementi della natura che devono essere estratti perché servono ad alimentare la costruzione di batterie e chip).
Si pensi a quell’economia dello scarto e dell’esclusione che aggrava le disuguaglianze, perché obbedisce solo al denaro. Quando la persona non è più al centro, quando fare soldi diventa l’unico obiettivo primario si costruiscono strutture di povertà, di schiavitù e di scarti.
L’adozione dell’automazione robotica al solo scopo di ridurre i costi, di essere efficienti sui turni di lavoro, può portare a condizioni di lavoro inique. Ha fatto notizia il primo sciopero dei lavoratori di Amazon che reclamavano condizioni salariali migliori, più dignitose, e un’organizzazione del lavoro più umana. Si pensi all’algoritmo di Deliveroo, “condannato” dal tribunale di Bologna (21/12/2020) perché nell’assegnazione dei turni favoriva i rider che facevano più consegne, senza distinguere tra i motivi delle assenze, spingendo quindi i lavoratori al massimo autosfruttamento, al fine di assicurarsi entrate dignitose. Il Tribunale di Bologna ha condannato Deliveroo per trattamento discriminatorio ai danni dei dipendenti.
Gli sforzi per creare un’etica dell’Intelligenza Artificiale possono essere condizionati dalle contingenze, soprattutto quando mettono a rischio i profitti di una grande azienda o gli interessi nazionali. Google, la multinazionale dal motto Don’t Be Evil (“Non fare del male”), ha licenziato negli ultimi tre mesi le due principali ricercatrici del suo team di etica dell’IA, Timnit Gebru e Margaret Mitchell[3]. Dopo aver denunciato la pericolosità sociale dei pregiudizi di alcuni sistemi di IA utilizzati da Google, sono state estromesse per aver “condiviso dati sensibili dell’azienda”.
Gli algoritmi stanno riducendo la nostra capacità critica, la possibilità di conoscere e di capire il mondo che ci circonda. Il potere, concentrato nelle mani di pochi, tende a voler dominare il pianeta e crea iniquità e disuguaglianze.
Oggi quante persone capiscono veramente il modello sottostante il mercato finanziario? A essere generosi forse l’1% della popolazione. Tra 10 anni, quando tutta la finanza si baserà sugli algoritmi, la percentuale di persone in grado di capire i modelli finanziari sarà pari a zero. Sappiamo che già oggi il 60% delle transazioni finanziarie sono fatte da macchine, a cui gli è stato imposto di creare capitale di rischio. La Borsa è diventata sempre più autoreferenziale, indirizzata verso un aumento del capitale di rischio e, piano piano, sta perdendo l’obiettivo di fare cose con un senso benefico. Eppure la Borsa (il mercato azionario) è nata come strumento per trovare capitali e fare attività a beneficio dell’uomo.
D’altra parte le macchine possono avere anche effetti distruttivi.
Si pensi ai sistemi di IA nel campo della difesa militare, i cosiddetti robot killer. Qualche anno fa il pentagono ha svelato l’idea di un progetto di uno sciame di droni intelligenti lanciato da aeri da combattimento che si autoregolano che sistemi di intelligenza artificiale per colpire meglio il nemico. E se pensiamo ai soldi che vengono investiti in IA in questo periodo (35,8 miliardi di dollari è la spesa mondiale in sistemi di IA nel 2019, il 44% in più rispetto al 2018), può diventare una tecnica sempre più potente, nel bene o nel male.
Pensiamo anche ai rischi di incorrere in “autoritarismi digitali”, a quei Paesi in cui il controllo totalitario della privacy delle persone a scopo di sorveglianza oppressiva sta diventando un’ossessione maniacale. I nuovi sistemi di riconoscimento usati in Cina, per esempio, non verificano soltanto i lineamenti del viso, ma vengono usati per controllare le emozioni delle persone, la loro origine etnica e lo stato di salute.
Gli autoritarismi digitali ci vogliono trasformare in esseri umani hackerabili, in cui la manipolazione “invisibile” di opinioni e scelte comportamentali incide direttamente sui beni primari della persona e della collettività. Vogliono avere il controllo dei nostri dati, delle nostre preferenze ma anche dei nostri dati biometrici, non solo per analisi predittive più accurate così da anticipare i nostri desideri di acquisto, ma per esercitare un controllo sociale e profilare il maggior numero di persone, mettendo così in pericolo la nostra uguaglianza e le nostre libertà.
La mancanza di leggi ad hoc dà completa libertà allo sviluppo di tecnologie di riconoscimento delle emozioni, sebbene numerosi attivisti dei diritti umani ne denuncino abusi e implicazioni sociali e legali. Evidentemente i rischi ci sono ed è necessario che se ne discuta pubblicamente. Dobbiamo conoscere i rischi e le implicazioni della digitalizzazione, ma non dobbiamo scaricare sulle macchine colpe di disoccupazione, disuguaglianze, guerre, sfiducia nella democrazia, e altri effetti distopici.
Vogliamo veramente dare la colpa alle macchine della nostra stupidità?
Digitale e Sostenibilità: una nuova alleanza per la qualità di vita e di lavoro
Se non è il robot che toglie il lavoro, così come non è il telefono, come non è la televisione o il pc, allora dobbiamo guardare da un’altra parte.
Il robot l‘abbiamo costruito noi e lo utilizziamo per fare certe cose. Non dobbiamo scordare che queste tecnologie le facciamo noi. È al modello di società che dobbiamo guardare, al modello di società che stiamo impostando utilizzando queste tecnologie.
Che significato allora possiamo dare all’essere umano nel mondo degli algoritmi?
Immaginiamo un mondo dove la robotica, l’intelligenza artificiale, le macchine sono indirizzare verso un modello di PIL diverso: per esempio verso l’ottimizzazione dei processi, verso un modello in cui utilizzare le tecnologie per ridurre l’impronta energetica in manifattura, i consumi di acqua e i consumi di CO2 in agricoltura, per fare agricoltura di precisione, per migliorare la chirurgia e la diagnostica.
Immaginiamo una fabbrica in cui gli esoscheletri vengono utilizzati non solo per aumentare la produttività del lavoro, ma per alleviare la fatica dei lavoratori, pensando al benessere di chi indossa l’esoscheletro e fa meno fatica, e poi arriva a casa meno stanco e ha meno probabilità di ammalarsi e più possibilità di vivere una vita migliore.
Questo è il messaggio che vorrei far passare. Abbiamo davanti l’opportunità di un modello alternativo. Le tecnologie possono aiutare a migliorare il benessere delle persone e a sviluppare un modello economico più sostenibile.
Avere un’agenda di sviluppo sostenibile significa ripensare ai parametri su cui calcolare il Pil, non basandosi più sul solo numero di pezzi prodotti e venduti. Da questo punto di vista l’intelligenza artificiale può dare una grossa mano, perché ha al suo interno tanti metodi e strumenti che ci possono aiutare. Questo è proprio un tema di constraint programming, di programmazione a vincoli, dove siamo chiamati a capire bene quali sono i vincoli che ci circondano, quali sono i desideri che vogliamo percorrere e capire quali gli strumenti che vogliamo mettere in piedi per arrivarci. È chiaro che puntiamo solo sul profitto e contabilizziamo solo il Pil corriamo il rischio di farci molto male.
Il Ministro della transizione digitale ha dichiarato che “l’innovazione digitale, in particolare l’IA, ha una caratteristica unica: quella di essere potenzialmente un grande equalizzatore di differenze. Permette di chiudere dei grandi gap: i gap territoriali perché ovviamente il digitale elimina le distanze; i gap sociali perché dà opportunità di fare quello che normalmente avrebbe avuto dei costi o delle barriere enormi; i gap di competenze, cosa che a me sta molto a cuore, perché permette a tutti di accedere alle migliori informazioni e competenze disponibili e fino ai gap individuali perché ognuno, grazie al digitale, può trovare la sua strada e quello che più si addice alla vita che vuole condurre”.
Ecco perché è importante tornare a parlare di organizzazione e di qualificazione del lavoro. Di investire sulle competenze del cittadino, di puntare sulla qualificazione dei lavoratori perché la scuola e la formazione non finiscono a 18 anni. Finiva a 18 anni quando poi per i successivi 40 anni che uno lavorava la tecnologia era sempre la stessa; ma siccome oggi il tempo di sostituzione tecnologica cambia a livello esponenziale, chiunque di noi dovrà aggiornarsi in continuazione.
Il diritto soggettivo alla formazione va esercitato in modo che sia formazione utile che fa crescere le persone, le quali devono accettare di farsi spostare verso le nuove frontiere del lavoro ibrido.
Purtroppo nell’istruzione e nella formazione abbiamo pezzi di fordismo vecchio stampo che faticano a essere abbandonati.
Lavori ibridi e metodi formativi (una sfida culturale non robotica)
La formazione può riguardare diversi aspetti: l’organizzazione aziendale, i processi e le competenze operative, le soft skills. Aspetti complessi, correlati tra di loro, che richiedono una formazione diversa da quella frontale, più tradizionale.
Il tipo di formazione che i lavori ibridi[4] reclamano è un approccio con metodologie “Plug&Play[5]”, coerente con i tempi compressi dei cambiamenti che scaricano sui lavoratori tanto la fatica ricorrente di imparare (dato l’elevato ritmo delle innovazioni tecnologiche e organizzative) che di disimparare (perché spesso tali cambiamenti rendono obsolete le pratiche lavorative consolidate), quanto lo stress di doverla fare in tempi molto rapidi, data la velocità con cui le novità vengono incorporate nella società, nei processi economici e produttivi.
La necessità di accompagnare i cittadini alla formazione digitale di base e specialistica è un tema improcrastinabile, non solo per rendere effettivi i diritti di cittadinanza, ma anche per avere una maggiore occupabilità dei lavoratori, per evitare di arrivare a una “doppia polarizzazione”.
La prima polarizzazione è tra chi sa e chi non sa.
Sappiamo che c’è una diffusa difficoltà nel rapporto con la tecnologia, tant’è che oltre quattro italiani su dieci possiedono competenze digitali basse o nulle. Il fenomeno varia a seconda dell’età (un italiano su due tra i cinquantenni, quasi sette su dieci nella fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni) e interessa anche i “nativi digitali”. Anche nella fascia di età più giovane (16-19 anni) la percentuale di chi ha competenze basse o nulle non scende mai al di sotto del 30%. In altre parole, anche tre “nativi digitali” su dieci in Italia frequentano in modo rudimentale e scarsamente consapevole gli strumenti digitali.
Ci sono poi i cosiddetti “tecnoesclusi”, quei cittadini tra i 16 e i 74 anni che non hanno mai usato internet, né dal computer, né da dispositivi mobili. Quanti sono in Italia? Più di quanti si potrebbe pensare: il 17% della popolazione adulta, quasi uno su cinque. L’esclusione dal mondo connesso riguarda in particolare persone con un basso livello di istruzione e che più spesso vivono nel Meridione. I dati sono contenuti nel “Annuario Scienza, Tecnologia e Società 2021” (pubblicato da Il Mulino) che riporta anche utili confronti internazionali: nell’Unione Europea la media dei “tecnoesclusi” è circa la metà, nove su cento, con punte superiori al 20% solo in Portogallo, Bulgaria e Grecia. Ma in Paesi come Finlandia, Svezia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi la tecnoesclusione è quasi sconosciuta e riguarda solo il 2% della popolazione.
La seconda polarizzazione è tra chi ha tutta una vita lavorativa davanti a sé e chi è (quasi) a fine carriera.
Se i lavoratori sono in età matura e con qualche decennio di esperienza alle spalle, il rischio di non riuscire ad apprendere e poter adeguare il proprio bagaglio di competenze è concreto, perché da una certa età in poi, la fatica di imparare per molti è insostenibile. Se le stime di alcuni istituti di ricerca si riveleranno corrette, nei prossimi anni nel settore della manifattura industriale ci saranno molti lavoratori con uno skill gap talmente elevato da non essere più impiegabili nei processi produttivi se non si rimetteranno in gioco.
Già oggi il gap tra domanda e offerta di lavoro nel settore ICT è molto alto, circa il 20% e sta aumentando; quasi tre italiani su dieci sentono di non avere sufficienti competenze digitali per svolgere il proprio lavoro (la media europea è del 18%; in Germania il 10%, nei Paesi Bassi solo il 7%).
In questa cornice emergono tre trend fondamentali:
1) In futuro l’apprendimento sarà sempre più incorporato nel lavoro, più connaturato all’attività svolta e riguarderà l’insieme uomo-macchina. In altri termini, entrambi impareranno nell’interazione, aggiungendo valore reciproco (human-machine learning). Questo è l’unico modo per stare al passo con attività produttive che, anche grazie alla tecnologia digitale, si trasformano continuamente.
2) I fabbisogni quali-quantitativi di ruoli e competenze emergeranno sempre di più “dal basso”, grazie alla cattura automatica dei comportamenti di persone e aziende. Sarà possibile predire, in modo sempre più preciso, di cosa avrà bisogno una persona per sostenerne la carriera e di quali lavori e competenze avrà invece necessità un’azienda.
3) La “formazione permanente”, intesa come alternanza, di luogo e di tempo, tra studio e lavoro sarà sostituita da “ubiquità” e “compenetrazione” che accomuneranno sempre più lavoro e apprendimento.
Il fatto che colossi tecnologici come Amazon, Apple, Google, Microsoft e Bertelsmann stiano investendo in modo così massiccio in istruzione e formazione non è casuale: nella nuova economia digitale, la capacità di assicurare reskilling e upskilling continui sarà alla base della competitività delle aziende e delle nazioni. Learning ed education costituiscono un enorme potenziale di business e si propongono anche come un nuovo campo da gioco per quella che una volta sarebbe stata chiamata “politica industriale”.
Secondo il World Economic Forum, entro il 2025, il 50% di tutti i lavoratori avrà bisogno di sviluppare nuove abilità e il 40% delle competenze di base degli attuali lavoratori cambierà. Le competenze digitali sono ormai richieste in sei assunzioni si dieci e con la pandemia sono di fatto esplose insieme all’aumento delle richieste per il digital marketing e in generale per l’e-commerce. Ci troviamo in un punto in cui la trasformazione digitale sta ridefinendo il futuro del lavoro. La conseguenza è scontata: pensare che ciascuno di noi o la nostra impresa non sarà toccata dal cambiamento in atto è utopico.
Sappiamo che in molte aziende si dà un giusto spazio alla formazione. Sono convinto che gioverebbe molto a un’azienda completare la formazione tecnica con una formazione ai valori: solidarietà, etica, giustizia, dignità, sostenibilità, significati sono contenuti che arricchiscono il pensiero e la capacità operativa.
Secondo un sondaggio condotto da Harvard Business Review Analytic Services, l’intelligenza emotiva è sempre più riconosciuta come un vantaggio competitivo. Verizon[6] ha intervistato i dirigenti aziendali senior sia prima che dopo il covid-19. Prima della pandemia, meno del 20% degli intervistati ha affermato che l’intelligenza emotiva sarebbe un’abilità importante per il futuro. Ma da quando c’è il Covid, l’intelligenza emotiva è aumentata di importanza per il 69% degli intervistati.
Anche se il mondo sta abbracciando rapidamente tecnologie sempre più complesse è ancora la connessione umana a fare la differenza.
Ciò rende l’intelligenza emotiva più importante che mai.
Verso la società 5.0
Se l’uomo resta al centro, egli sarà anche il maggiore fruitore dei vantaggi portati dalle nuove tecnologie, con le macchine che offriranno servizi sempre più flessibili e personalizzati. Si tratterà di continuare quello che storicamente l’umanità ha fatto in passato, riassegnando e redistribuendo i benefici della tecnologia a crescenti fette di popolazione. Quindi la locuzione “l’uomo al centro” non deve essere un auspicio o un’indicazione etica, ma un vero e proprio programma di lavoro.
In questo senso i pionieri, ancora una volta, sono i giapponesi che, spinti anche dalla popolazione più anziana del mondo, hanno annunciato per primi la società super smart, la Società 5.0.
Lanciato nel programma governativo “5th Science and Technology Basic Plan”, già nel 2016, la società 5.0 segue quella basata sulla caccia (società 1.0), quella agricola (società 2.0), quella industriale (società 3.0) e quella informatica (società 4.0). Lo scopo è creare una società con l’uomo al centro, che bilanci i progressi economici con la risoluzione dei problemi sociali attraverso un elevato grado di integrazione tra cyberspazio e spazio fisico.
Se il paradigma di Industria 4.0 si incentra principalmente sulla prospettiva tecnologica e punta molto sull’automazione e digitalizzazione dei processi produttivi, ma trascura l’aspetto sociologico, il paradigma di Industria 5.0 implica la penetrazione dell’intelligenza artificialenella vita comune delle persone e la sua cooperazione, con l’obiettivo di sfruttare le tecnologie abilitanti per “la creazione di una nuova società intelligente che aiuta a risolvere le questioni sociali piuttosto che generare semplici miglioramenti della produttività”.
L’idea visionaria è quella di superare le barriere di età, genere, lingua e geografiche grazie all’utilizzo intelligente e responsabile delle nuove tecnologie. E qui il balzo in avanti: oltre a migliorare i processi produttivi, i prodotti e i nuovi modelli di business, utilizzare l’innovazione tecnologica per puntare al miglioramento delle condizioni di vita con relativa soluzione dei problemi sociali. Si pensi alla mobilità per gli anziani, alla cura della salute, alle città che adattano i traffici, i riscaldamenti le illuminazioni in funzione delle condizioni ambientali cangianti. Nella Società 5.0 l’obiettivo è capire come la tecnologia può aiutare le persone a soddisfare i propri bisogni ed essere felici, integrando le più avanzate tecnologie nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, per creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro.
La quinta rivoluzione industriale si baserà su un’industria collaborativa focalizzata sulla cooperazione tra uomo e macchina: un modello di impresa caratterizzato dalla cooperazione tra sistemi ed esseri umani, con l’obiettivo di far lavorare in armonia l’intelligenza umana con quella artificiale.
Industria 5.0 valorizzerà ulteriormente la capacità intellettiva e la creatività umana. Tutto questo richiederà nuove figure professionali, come il chief robotics officer (CRO): un esperto nella comprensione dei robot e delle loro interazioni con gli umani che sarà responsabile di prendere decisioni su macchine o robot per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali.
Più che a una sostituzione del lavoro umano, assisteremo quindi allo sviluppo di una ‘super smart society’, governata dalla cooperazione intelligente tra esseri umani e macchine.
Umanesimo digitale e Algoretica: vale di più la borsa o la vita?
Se non sono le macchine a rubarci il lavoro, cosa ci dobbiamo aspettare, dobbiamo essere ottimisti o pessimisti?
Dobbiamo comportarci da luddisti, esercitando forme di lotta contro le nuove macchine o resistendo al mutamento tecnologico?
Persino Ned Ludd, il giovane che nel 1779 distrusse un telaio in segno di protesta e divenne simbolo della distruzione delle macchine industriali, avrebbe capito che il problema non erano le macchine.
Sicuramente dobbiamo essere cosci e consapevoli dei rischi delle tecnologie, per portarle verso utilizzi a fin di bene.
I robot e l’intelligenza artificiale interrogano l’aspetto etico, quella che si chiama algoretica. Secondo l’Accademia della Crusca l’algoretica è lo studio dei problemi e dei risvolti etici connessi all’applicazione degli algoritmi. Se dovessimo parlare di etica e di tecnologie con una metafora cittadina, potremmo dire che è come Central Park a New York: potete costruire ovunque ma lì no. Negli USA le grandi compagnie tecnologiche grazie ai sistemi di IA hanno assunto un potere sociale enorme ed è come se volessero restringere sempre di più il perimetro del parco, dotandosi di un’etica autonoma evitando l’intromissione del potere nazionale.
È giusto allora interrogarsi se sia possibile continuare in questa direzione.
Torniamo all’interazione tra uomo e macchina, in cui sia chiaro l’intento dell’azione meccanica.
Una coesistenza dell’uomo e del robot che richiede che la macchina sia trasparente per l’uomo, che i fini del suo agire non siano nascosti dietro un algoritmo, magari protetto da copyright o da un brevetto. Io devo poter interagire con la macchina, devo capire quali sono i suoi fini. Quando un essere umano e una macchina dialogano insieme e coesistono all’interno di uno stesso ambiente, quello che accade è che l’uomo ha degli obiettivi e la macchina ha degli obiettivi.
E qual è il giusto obiettivo della macchina, quali vincoli deve rispettare
Lo deciderà la priorità dell’uomo. La macchina deve adeguare i suoi obiettivi e le sue finalità a quelli che sono gli obiettivi umani, perché è l’uomo che in quel momento riconosce qual è il valere del valore e dice alla macchina qual è il primo valore che deve essere messo in atto, il primo da realizzare.
Se la questione etica tornerà ad abitare al centro, tutti questi nuovi artefatti tecnologici saranno in grado di aumentare le capacità del nostro fare, senza negare il valore che siamo.
Siamo esseri umani, emotivi, non meccanici. In un periodo di transizione che pone tanti interrogativi, in un anno nel quale la vita si è trasferita dietro agli schermi, più che di un nuovo luddismo o di un cieco ottimismo, abbiamo bisogno di vivere le domande del nostro tempo.
Cosa potranno o non fare le macchine, i robot nelle loro più diverse forme materiali o immateriali?
Quali saranno le responsabilità derivanti dalle loro azioni?
Personalmente ritengo che il mondo che verrà potrà essere migliore dell’attuale e che l’uomo potrà beneficiare dei vantaggi enormi che la tecnologia saprà offrire. Questo richiederà un approccio consapevole, informato e responsabile.
Bisognerà evitare la contrapposizione ideologica tra neo luddisti e ottimisti a tutti i costi; bisognerà affrontare con determinazione e professionalità il tema del controllo delle tecnologie e degli strumenti per farlo (molti dei quali, probabilmente, devono essere ancora inventati): bisognerà avere una gran voglia di partecipare a questa grande partita da attori principali, senza fermarsi sulla superficie dei temi.
Un sistema sociale è giusto se consente a ogni cittadino di cercare la propria felicità, di mettersi in cammino verso quella che è la propria autorealizzazione.
Uguaglianza e ricerca della felicità è un driver etico che non può stare fuori dall’intelligenza artificiale. Ma l’etica da sola non basta. Se non c’è un diritto, se non ci sono delle regole, l’etica è una voce che arriva alla parte più profonda di noi, ma come una voce può essere ignorata. Ecco allora che quella voce deve diventare delle direttive, deve diventare qualcosa che plasma l’innovazione dandole una forma che noi vogliamo.
È necessario, insomma, evitare i rischi di applicazioni dell’IA in contrasto con i diritti umani e l’utilità sociale. Occorre, quindi, agire con equilibrata regolazione che premi il grano e bandisca il loglio affinché l’IA esprima le potenzialità di sviluppo sostenibile e non accresca le storture di un modello capitalistico che ha bisogno di essere messo a punto: nel senso che la separazione del grano dal loglio deve investire la realizzazione in sé di risultati (prodotti, procedimenti, algoritmi) contrati a diritti umani, la non brevettabilità dei quali (in quanto privi dell’essenziale requisito della liceità) dovrà essere un ovvio corollario, così come avvenuto in passato con le Convenzioni e le leggi che hanno vietato la produzione e il commercio di certe sostanze velenose, gas tossici, materiali pedopornografici e via dicendo.
La strada delle regole per lo sviluppo delle tecnologie digitali è appena iniziata ma si interseca con quella della ricerca di strumenti di protezione e incentivazione dei frutti dell’innovazione robotica.
Stephen Hawking ha detto che “L’intelligenza artificiale sarà la cosa migliore o peggiore mai successa all’umanità”.
Sta a tutti noi, dai cittadini, ai ricercatori, a chi lavora nelle imprese, a chi lavora nei servizi pubblici, cercare di indirizzare le nuove tecnologie verso il bene e rimettere l’uomo al centro dell’Universo.
L’intelligenza artificiale e la biotecnologia nel XXI secolo trasformeranno il mondo ma noi possiamo usare queste tecnologie per creare diverse tipologie di società.
Di fronte al diluvio dell’IA la domanda etica più antica torna fondamentale: vale di più la borsa o la vita?
[1] Cfr. The digital economy and the euro area, all’interno del Bollettino Economico della BCE n. 8/2020: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_03~da0f5f792a.en.html#toc1
[2] I lavori più sicuri di domani, che non saranno replicati da un robot o da un algoritmo, sono quelli che richiedono creatività (progettazione, ingegneria), che richiedono ai lavoratori di stabilire relazioni empatiche con altri (insegnati, infermieri), ruoli aziendali che richiedono una comprensione emotiva dei clienti per ottenere i massimi livelli esperienza del cliente (design), lavori commerciali che richiedono molta mobilità e flessibilità in ambienti imprevedibili (elettricisti, idraulici) e lavori artigianali (falegname, ceramista e creatore di tessuti) che incorporano elementi di competenze tecniche a base artigianale considerate di qualità superiore.
[3] Cfr. https://www.bbc.com/news/technology-56135817
[4] Per lavoro ibrido si intende un lavoro che “combina” e “integra” le competenze tecniche, gestionali, professionali o relazionali con le competenze informatiche e digitali, le conoscenze per comunicare nei social network, le abilità per interagire con altre persone attraverso la mediazione o l’uso di tecnologie digitali, gli orientamenti per svolgere in modo efficace la propria attività in ambienti di lavoro in cui lo spazio (fisico e sociale) e il tempo (aziendale e personale) assumono configurazioni diverse.
[5] L’uso delle metodologie Plug&Play per la formazione nasce nell’ambito dell’Operations management. L’obiettivo di metodologie di questo tipo è quello di fornire agli studenti la possibilità di acquisire un’esperienza pratica diretta di quanto viene insegnato in aula. Questo fa sì che, in aggiunta alle lezioni tradizionali, vengano sommate alle attività formative anche simulazioni, esercitazioni e giochi. L’apprendimento attraverso i giochi diventa quindi un modo interattivo per acquisire conoscenza, in cui gli studenti partecipano attivamente al processo in corso.
[6] https://www.nasdaq.com/articles/corporate-leadership-2.0%3A-is-emotional-intelligence-the-new-iq-2020-11-19