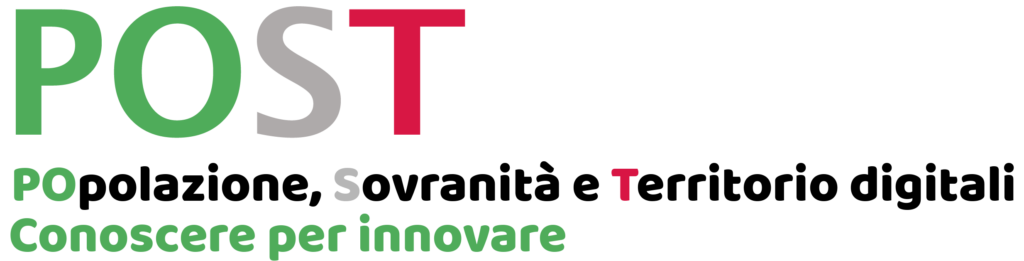Il rischio di default nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza
Di Michele Vietti
Cos’è il default?
Senza voler entrare nello specifico della definizione di default, applicando una traduzione un po’ “maccheronica”, siamo abituati ad accostarlo a termini quali “tracollo economico”, “bancarotta”, “fallimento” e “fallito”, con ogni tragica accezione che, in particolare, queste ultime parole hanno nel linguaggio, non solo giuridico, italiano.
Pertanto la prima, istintiva, reazione suscitata dalla notizia della classificazione di un debitore “allo stato di default” è quella di evocare situazioni quali la perdita della disponibilità e dell’amministrazione di tutti i beni, l’impossibilità di compiere ogni atto di disposizione del patrimonio e, ovviamente, il diritto a percepirne i frutti.
Tuttavia il termine, così come inteso dall’art. 178 del Regolamento europeo relativo ai requisiti per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Reg. UE 575/2013) ha una portata molto più aderente alla traduzione letterale della parola inglese: difetto, inteso come la situazione deficitaria di un soggetto, che intrattenga rapporti economici con terzi, di rispettare puntualmente (anzi, al centesimo, visti i rigidissimi parametri stabiliti) le obbligazioni assunte.
Infatti, il nuovo concetto di default riguarda la procedura con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali: “non performing”, in presenza di crediti deteriorati, o “performing”, con conseguenti diversi accantonamenti per rettifiche di valore del conto economico dell’ente affidante.
La disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, i debitori siano classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante (past due);
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).
Gli intermediari finanziari applicano la disciplina sul default avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, possono considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione).
Tale definizione è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.
Il Regolamento delegato stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
una soglia assoluta
100 euro per le esposizioni al dettaglio (privati e PMI)
500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (imprese medio-grandi)
una soglia relativa
l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte
Fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari la soglia relativa è pari al 5% dell’esposizione.
Superate entrambe le soglie, verranno concessi al cliente 90 giorni di tempo (o 180 in alcuni casi, per esempio per le amministrazioni pubbliche) per ripianare il debito. Scaduto tale lasso di tempo, il debitore è classificato in stato di default.
È importante rilevare che la nuova definizione di default non modifica (almeno nella sostanza) i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela (non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, come chiaramente segnalato da Banca d’Italia nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale), ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.
Per questo motivo, la Banca d’Italia ha inviato una comunicazione per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.
Ma cosa c’entra tutto questo con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza?
Per capire il motivo per cui questa nuova classificazione dei debitori – e le sue conseguenze pratiche – potrà avere un rilevante impatto sull’insolvenza delle imprese, occorre fare un breve passo indietro.
*
Come noto, il 12 gennaio 2019 è stato emanato, dopo un anno di lavori, il D. Lgs. 14/2019, il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (di seguito “CCII”).
Il testo è stato presentato come epocale modifica organica e sistematica della disciplina delle procedure concorsuali (ed in effetti, lo è), ma sin dall’inizio ha sollevato diverse polemiche in ordine alla sua idoneità ad attuare quella autonomia, snellezza e efficacia delle procedure che costituivano l’obiettivo della legge delega n. 155/2017.
La consapevolezza dell’esigenza di rimaneggiare gli impianti del 1942 non è affatto nuova.
Già la riforma del 2005 (in cui chi scrive ha avuto qualche parte) modificava in modo sostanzioso le norme della Legge Fallimentare, abbandonando definitivamente il concetto di ”economia nazionale”, l’idea che lo Stato ne sia il gestore, nonché la concezione che l’impresa in insolvenza vada “punita”: le sanzioni al fallito vengono rimosse e viene operata quella che qualcuno ha definito “privatizzazione del fallimento”.
In realtà non c’è mai stata una privatizzazione vera e propria, ma certamente l’obiettivo delle procedure di insolvenza è stato spostato dall’asse Stato/Curatore – fallito a quello debitore/creditori, affidando a quest’ultima dinamica dialettica la nuova regolamentazione della crisi, espungendo l’interesse nazionale e limitando, nell’ambito regolatorio, il potere del giudice, considerato ancora dal Regio Decreto la longa manus del potere sanzionatorio dello Stato.
Della spinta riformatrice si è fatto portatore anche il legislatore europeo con il Regolamento 2015/848, avente ad oggetto specificamente le procedure di insolvenza ed il loro ruolo nel mercato interno in relazione ai rapporti e alle relazioni transfrontaliere, e con la Raccomandazione 135/2014 della Commissione, che ha introdotto due importanti concetti:
- l’emersione tempestiva della crisi e la conseguente opportunità di ristrutturazione in fase precoce;
- l’idea di offrire al debitore una “seconda chance”, molto cara alla cultura anglosassone e quasi sconosciuta all’esperienza italiana.
Quello che l’Europa ha chiesto di recuperare è la nozione secondo cui il rischio di impresa non può coincidere né con il rischio penale, né con il rischio di pregiudizievoli conseguenze civili quasi indelebili.
Se tutti gli imprenditori avessero successo, vivremmo nel paradiso terrestre: fare impresa è per sua natura correre un rischio, diversamente il legislatore non si sarebbe preoccupato di approntare strumenti come le società di capitali e la responsabilità limitata.
Il legislatore della Riforma non mi pare abbia fatto fino in fondo buon uso di questi principi ispiratori, muovendosi piuttosto in una logica di controriforma in cui la gestione della crisi torna, per lo più, nelle mani pubbliche e sfugge al controllo delle parti.
Esemplari da questo punto di vista sono le interpolazioni che il Codice della crisi introduce nel Codice civile.
L’art. 2086 cod. civ., rubricato ora “Gestione dell’impresa”, dopo il primo comma originario secondo cui “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”, recita, al secondo comma, frutto della modifica del 2019, “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La norma fa riferimento all’imprenditore in generale, non all’imprenditore della società di capitali, imponendo di istituire in tutte le imprese un assetto “organizzativo, amministrativo e contabile” adeguato alle dimensioni dell’impresa anche – ma forse andrebbe inteso come “soprattutto” – in funzione dalla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
È altresì fatto carico all’imprenditore di attivarsi senza indugio per l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Appare assai improbabile che un comune piccolo imprenditore possa essere in grado – soprattutto economicamente – di predisporre quell’assetto che il novellato codice civile pretende da lui.
Verrebbe da dire che – nell’idea del legislatore – la priorità dell’imprenditore non è più fare profitto, rischiare, essere competitivo sul mercato, utilizzare – ovviamente nei limiti del lecito – tutte le chance commerciali al fine di produrre ricchezza, ma è organizzare l’impresa in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Nella definizione di imprenditore, la prima prospettiva che il codice civile evoca per chi vuole intraprendere l’attività d’impresa è quella della crisi, con una sorta di richiamo escatologico al “Ricordati che devi morire”.
*
Non pago dell’affermazione di carattere generale, il legislatore, nell’art. 377 CCII, impone di trasporre la novità dell’art. 2086 cod. civ. in tutti i modelli societari.
La società semplice, per definizione lo strumento più informale che il nostro ordinamento ha (o aveva) per svolgere l’attività di impresa in forma associata – che può persino essere costituita di fatto e che rappresenta la forma più elastica possibile di rapporto societario – vede modificato l’art. 2257 cod. civ..
Già la riforma del 2019 aveva introdotto al primo comma (“salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”) la previsione: “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086”.
A seguito della novella del 2020, l’articolo adesso recita: “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”.
Anche la società semplice deve perciò preoccuparsi di avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale alla rilevazione ed emersione tempestiva della crisi, alla continuità aziendale e all’adozione dei provvedimenti per superarla, mentre la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che compiono il necessario per l’attuazione dell’oggetto sociale: il legislatore prende così a prestito la nozione di amministrazione tipica delle società di capitali e la traspone nella società semplice, violandone l’impianto e la natura.
Stessa operazione viene effettuata per le società per azioni con la modifica degli artt. 2380 bis cod. civ. e 2409 novies cod. civ. (per le S.p.A. con sistema di amministrazione e controllo dualistico).
In questo caso, il d.lgs. 147/2020 ha demandato agli amministratori ovvero al consiglio di gestione l’onere di istituire adeguati assetti organizzativi societari.
Infine, per le società a responsabilità limitata, l’art. 2475 cod. civ. prevede che “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”.
La modifica si configura come una forzatura rispetto al modello della S.r.l. che il legislatore della riforma societaria ha voluto costruire come più vicino alla società di persone che alla società di capitali, contraddistinto da una elevata autonomia privata, soprattutto nel riparto di competenze gestionali tra gli amministratori e i soci, in cui è possibile demandare una serie di attività gestorie ai soci.
Peraltro non ci si è preoccupati della compatibilità con l’art. 2479 cod. civ. in cui invece sono elencate le decisioni dei soci ed è ancora presente – anche a seguito del correttivo 2020 – la possibilità di demandare a loro i compiti propri dell’organo gestorio.
*
Già prima della sua integrale entrata in vigore – originariamente fissata al 15 agosto 2020, poi prorogata al 1° settembre 2021 – il Codice è stato oggetto di diverse modifiche, la più recente ad opera del già citato correttivo approvato con il d.lgs. 147/2020.
Per quanto qui interessa, la modifica maggiormente significativa è quella dell’art. 13 CCII, adesso rubricato “Indicatori e indici della crisi”.
L’obbiettivo fondamentale del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il suo principale elemento di innovazione e leitmotiv sembra essere proprio l’emersione immediata delle difficoltà d’impresa e la “diagnosi precoce” della crisi, da attuarsi mediante l’imposizione di obblighi di segnalazione finalizzati “alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione” (art. 12 CCII).
Secondo la nuova (pressoché solo nel titolo) formulazione della norma, “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24”.
Il successivo comma aveva già assegnato il compito di elaborare questi indici, necessari al completamento del sistema dell’allerta, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T. – in modo che gli stessi, valutati unitariamente, potessero far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa ed indurre i preposti organi a porvi tempestivo rimedio.
Gli indizi di crisi attengono alla manifestazione dell’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (rappresentativa della crisi dell’impresa) e scaturiscono, in prima battuta, dagli obblighi segnaletici di cui all’art. 14 CCII a carico degli organi di controllo societari, nonché dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, i quali hanno l’obbligo di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario, il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Con un documento pubblicato il 20 ottobre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha finalmente individuato gli indicatori e definito, in relazione alle categorie settoriali, delle soglie per i vari indici che – valutate unitariamente e tenendo conto delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali – dovrebbero fornire ragionevoli presunzioni di crisi dell’impresa.
Gli indicatori individuati dal CNDCEC, (che – benché già definitivi – devono ancora essere recepiti dal Ministero dello sviluppo in un apposito decreto), sono:
- patrimonio netto negativo o al di sotto del minimo legale[1];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR). L’unico indicatore individuato che utilizza dati prognostici ed è calcolato come rapporto tra i “cash flow liberi” (ossia i flussi di cassa della gestione corrente) previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale[2];
- qualora non sia disponibile il DSCR, dovrà essere valutato il superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari[3];
- indice di adeguatezza patrimoniale[4];
- indice di ritorno liquido dell’attivo[5];
- indice di liquidità[6];
- indice di indebitamento previdenziale e tributario[7].
Gli indici andranno applicati e valutati secondo una sequenza gerarchica progressiva: in particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella propria relazione, ha precisato che “gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le cinque soglie stabilite per tali indici”.
In base al già citato art. 14 CCII, nonché per il rispetto del parametro di “tempestività” dell’istanza agli Organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) di cui al successivo art. 19 CCII, gli organi di controllo avrebbero l’onere di segnalare i fondati indizi della crisi all’organo amministrativo al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici, il che comporterebbe l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale.
E’ interessante rilevare che, in assenza di un bilancio approvato, gli obblighi di controllo dovranno essere assolti attraverso una relazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario che potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico.
Pertanto, per le imprese che non hanno obbligo di bilancio, la corretta applicazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi è interamente rimessa all’onestà ed alla buona fede dell’imprenditore.
*
Gli organi di controllo societario – revisori contabili, società di revisione, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo sulla gestione, a seconda dei modelli – hanno pertanto un duplice obbligo: i) verificare che l’organo amministrativo monitori l’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile, dell’impresa, lo squilibrio finanziario ed economico e il prevedibile andamento della gestione e ii) segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
L’organo di controllo dovrà quindi prima tentare un’interlocuzione con l’organo amministrativo e, nel caso in cui lo stesso non si adoperi adeguatamente, dovrà attivare la procedura di allerta esterna, segnalando all’OCRI gli elementi di crisi; tutto ciò persino in deroga, prevede l’art. 14 CCII, a quanto previsto dall’art. 2407 cod. civ. (“i sindaci […] devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”).
Solo la tempestiva segnalazione agli Organismi di composizione della crisi esonera gli organi di controllo dalla responsabilità solidale, il che, probabilmente, indurrà gli stessi ad assumere un atteggiamento auto-protezionistico, denunciando “precauzionalmente” ogni variazione economica con segno negativo, anche minimo, dell’impresa.
Una volta ricevuta la segnalazione, il referente tramite il quale opera l’OCRI (individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato) ha il compito di nominare un collegio di tre membri.
Il collegio convocherà il debitore e si occuperà di una sorta di attività istruttoria a seguito della quale, rilevata l’esistenza della crisi ricercherà una soluzione concordata.
L’intera procedura di allerta e di composizione assistita della crisi si basa sul presupposto della riservatezza, poiché finalizzata ad indurre il debitore a far emergere la difficoltà – invece che ad occultarla – sulla garanzia che questo non pregiudicherà la continuità aziendale.
Nonostante ciò, l’art. 22 CCII, posto a chiusura del capo dedicato al procedimento, prevede che quando la condotta del debitore nella procedura di allerta o nella procedura di composizione assistita non possa qualificarsi come in buona fede (perché il debitore non compare all’audizione, oppure non presenta istanza per la ricerca di una soluzione concordata, o non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi), dovrà essere effettuata la segnalazione al Pubblico Ministero, il quale ovviamente potrà esercitare le azioni a lui riservate dal Codice della crisi.
La previsione della segnalazione al PM è palesemente in contraddizione con l’obiettivo di massima riservatezza che la procedura si proponeva.
L’incoerenza è ancor più evidente a seguito del decreto correttivo del 2020 che ha rafforzato i poteri del Pubblico Ministero, già disciplinati all’art. 38 CCII.
Oltre alla facoltà, già attribuita al Pubblico Ministero, di presentare “ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza” (comma 1) e all’obbligo di segnalazione al PM da parte “dell’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento” (comma 2), è stato specificatamente attribuito al Pubblico Ministero, dal nuovo comma 3, il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).
Si è inoltre disposto che le relazioni del commissario giudiziale debbano essere trasmesse al Pubblico Ministero al fine di poter facilitare il potere di intervento nella procedura di concordato preventivo.
Se è pur vero che il dichiarato scopo della disposizione dell’art. 38 CCII è quello di restituire “centralità al ruolo del PM coerentemente col ruolo attribuito a tale organo nella procedura di allerta” (come freudianamente affermato nella Relazione Illustrativa al CCII), è chiaro che la previsione di poteri tanto invasivi non potrà che compromettere il funzionamento della procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, scoraggiando il debitore dal far emergere le difficoltà dell’impresa.
*
L’art. 379 CCII nel tentativo, lodevole ma velleitario, di diffondere anche nelle imprese di minori dimensioni una maggiore cultura sul controllo di gestione e su una organizzazione contabile e amministrativa più efficiente, aveva modificato l’art. 2477 cod. civ. prevedendo per le S.r.l. l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Tuttavia, a seguito di critiche in merito alla non sostenibilità dei costi dell’organo di controllo per le società aventi le predette “dimensioni”, il terzo comma dell’art. 2477cod. civ. è stato nuovamente modificato dall’art. 2 bis, comma 2, d.l. n. 32/2019, convertito nella legge n. 55/2019, in vigore dal 18 giugno 2019, che ha raddoppiato tutti e tre i limiti.
Peraltro, sempre in ragione delle modifiche di cui al d.l. n. 32/2019, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti.
*
Con riferimento ai momenti di operatività e di superamento dei parametri di cui all’art. 2435 bis cod. civ.[8] – per la redazione del bilancio in forma abbreviata – la dottrina ritiene che occorra far riferimento alla avvenuta formazione del bilancio di esercizio (non essendo necessaria, da parte degli amministratori, una convocazione ad hoc dell’assemblea) che rappresenta il presupposto ai fini dell’accertamento dei livelli previsti per l’attivo dello stato patrimoniale e per l’entità dei ricavi.
Si afferma, in dottrina, che al venir meno dei parametri legali si verifica un’ipotesi di decadenza del sindaco o del revisore, con la conseguenza che alla successiva deliberazione dei soci va attribuito funzione non già di revoca, ma di dichiarazione di accertamento di un effetto giuridico già prodottosi, così che non è necessario seguire la procedura di cui all’art. 2400, comma 2 cod. civ..
Infine, il penultimo comma dell’art. 2477 cod. civ. prevede che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
E’ interessante rilevare che l’articolo recupera una, ormai, inedita e vasta autonomia allo statuto in ordine ai controlli nell’ambito della società a responsabilità limitata.
È, infatti, previsto che l’atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri (ivi compresa la revisione legale dei conti) la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
L’esplicarsi dell’autonomia privata ha a riferimento anche la composizione dell’organo il quale potrà essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale: in difetto di previsione statutaria, però, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
*
Alla luce di quanto esposto, il collegamento tra la nuova definizione di default e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza induce a qualche preoccupata conclusione.
Non solo la classificazione in default di un’impresa ben potrebbe costituire indice della crisi – ed arrivare ad imporre le procedure di allerta – ma le (non ancora definite) conseguenze di questa classificazione potrebbero accelerare (se non addirittura determinare) l’insolvenza dell’imprenditore.
Infatti, come accennato, è possibile addivenire ad una dichiarazione di default anche con riferimento a debitori che, pur non avendo arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano – a giudizio dell’intermediario – in grado di adempiere le obbligazioni assunte se non attraverso l’escussione delle garanzie prestate a copertura del credito, ovvero, in caso di posizione creditoria unsecured, non siano ritenuti in grado di adempiere puntualmente le obbligazioni assunte.
L’EBA nelle Linee Guida, al fine di contenere l’ampia discrezionalità riconosciuta agli intermediari circa la possibilità di ricondurre una posizione unlikely to pay nel novero di quelle in default, ha definito una serie di triggers in presenza dei quali la posizione deve essere qualificata come “deteriorata”, che però non appaiono idonei ad evitare, almeno in un primo momento di assestamento della disciplina, una serie indiscriminata di segnalazioni prudenziali in default dei debitori.
Se, come è probabile, la classificazione in default limiterà la possibilità del cliente di beneficiare di linee di credito da parte (quanto meno) dell’Istituto segnalante, è facile comprendere quanto tale conseguenza sarà impattante in un’economia come la nostra, che postula lo “sconfinamento” temporaneo come vera e propria modalità standard di gestione dell’attività d’impresa.
Nonostante, nelle FAQ predisposte, Banca d’Italia abbia chiarito che le nuove regole non introducono un divieto a consentire sconfinamenti, sempre possibili sulla base del singolo contratto tra la banca e il cliente (e specie se la banca prevede la presenza di fidi), la normativa identifica chiaramente delle soglie, superate le quali, l’intermediario deve classificare in default il debitore.
Un’ulteriore novità connessa alla nuova definizione, attiene al fatto che non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con eventuali altre disponibilità presenti su diverse linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate: in tal caso, la banca sarà comunque tenuta a classificare il debitore in default.
Parimenti, appare significativo il c.d “contagio del default” in forza del quale, qualora sia applicata la nozione di default non a livello di singola linea – in caso di obbligazioni congiunte – se il rapporto cointestato è in default il contagio si estende alle esposizioni dei singoli cointestatari, mentre se tutti i cointestatari sono in default il contagio si estende automaticamente alle esposizioni oggetto della cointestazione.
Ciò anche alla luce del fatto che, se un cliente viene qualificato come in default presso una società del gruppo bancario, tale qualificazione si estende a tutte le società del gruppo.
Infine, è riconosciuta la possibilità per il debitore di “uscire” dalla condizione di default qualora siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all’art 178 del Regolamento 575/2013 (e, pertanto, il debitore abbia regolarizzato la sua posizione), ovvero un anno avuto riguardo ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso si stia rispettando il piano/accordo), fermo restando che oggetto di valutazione dell’intermediario debba essere la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore, con ritorno in bonis solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.
*
Il combinato disposto della nuova procedura di default e delle nuove procedure di allerta, che registrano una crisi dell’impresa ma non sono in grado di governarla fino in fondo, rischia di produrre un cortocircuito penalizzante per il sistema economico.
La contingenza emergenziale dovrebbe indurre il legislatore nazionale e comunitario a rivalutare l’impatto di misure pensate in un’altra epoca e per un’altra crisi, evitando di far trovare il mercato, se e quando si riprenderà, nella morsa di un nuovo dirigismo in cui lo Stato insegna agli imprenditori a fare il loro mestiere.
[1] Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, ex art. 2424 cod. civ.), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426, comma 1, n. 11 bis, cod. civ..
[2] Valori inferiori ad 1, dovrebbero far azionare gli alert aziendali.
[3] Rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato.
[4] Rapporto tra patrimonio netto e debiti totali.
[5] Rapporto da cash flow e totale attivo dello stato patrimoniale.
[6] Rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine.
[7] Rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e totale attivo dello stato patrimoniale.
[8] 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.